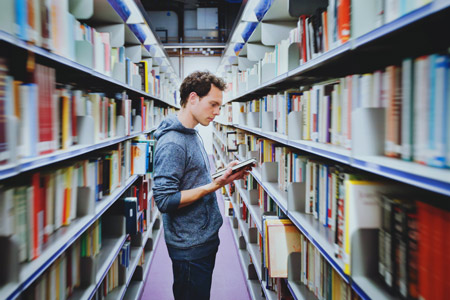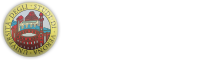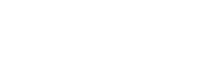- Autori:
-
Cusinato, Guido
- Titolo:
-
Katharsis. La morte dell'ego e il divino come apertura al mondo nella prospettiva di Max Scheler, con una Prefazione di Manfred. Frings, (402 pp.)
- Anno:
-
1999
- Tipologia prodotto:
-
Monografia o trattato scientifico
- Tipologia ANVUR:
- Monografia o trattato scientifico
- Lingua:
-
Italiano
- Formato:
-
A Stampa
- Casa editrice:
- ESI
- ISBN:
- 8881149125
- Parole chiave:
-
Platone; Schelling; Schopenhauer; Nietzsche; Husserl; Scheler; fenomenologia; riduzione; etica
- Breve descrizione dei contenuti:
- Questo lavoro si sviluppa sia su di un piano filologico che teoretico.
1) Relativamente a quello filologico l'intenzione preponderante è quella di superare le consuete interpretazioni della riduzione fenomenologica di Husserl e Scheler per dimostrare una connessione con il concetto platonico di katharsis. La riduzione fenomenologica è una epoché dell'ego. Altrettanto Platone nelle Leggi con il processo di purificazione o katharsis non intende anticipare la morte come fuga dal mondo, ma promuovere la "morte dell'egocentrismo". La morte dell'egocentrismo tuttavia non significa l'annullamento della singolarità individuale, ma al contrario è il punto di partenza di una filosofia come esercizio di trasformazione. Questo concetto è il vero nucleo dell'epoché fenomenologica.
2) Sul piano teoretico la tesi di questo lavoro è che ogni azione che si muova nel senso d’un incremento del grado d’apertura al mondo, attraverso il superamento della propria intrascendenza, sia un’azione etica. Anzi che l’etica consista proprio in quest’incremento. Con "morte dell'ego" s'intende il superamento di un certo tipo di soggettività: quella che chiudendosi nella propria autoreferenzialità e nel mito immunitario della propria autonomia sovrana non è mai stata in grado d'inaugurare un processo di formazione e di trasformazione della persona. Tale katharsis o "morte dell'ego" non ha quindi nulla a che fare con il processo oblativo e sacrificale del proprio sé che culmina nell'amor mortis: con "morte dell'ego" s'intende piuttosto un processo di svuotamento dalla saturazione egocentrica per inaugurare un processo di formazione dell'identità personale nel legame con l'altro. La morte dell'ego diventa allora il punto di partenza etico della filosofia come superamento del mito prometeico dell'individuo inteso come monade autosufficiente e contemporaneamente scoperta dell'incompiutezza antropologica dell'uomo.
Le due questioni sono strettamente intrecciate e rinviano a un problema che è sempre stato presente nel pensiero greco e cristiano. Già in un passo della Lettera ai Filippesi, Paolo nota: «la loro fine è la perdizione, il loro dio è il ventre» (3, 19). Anche il «ventre» ha infatti le sue esigenze, anche il ventre ha gli «occhi»: se l’uomo si riduce a guardare il mondo attraverso gli occhi del proprio «ventre» allora è dannato, ma non nel senso che verrà poi condannato da un qualche tribunale celeste quanto che già in tale condizione è implicito un danno esistenziale, una chiusura e un ripiegamento della vita su se stessa. L’etica mi pare in primo luogo un invito ad evitare tale danno. Platone nel Fedone concepisce la catarsi come passaggio da un certo modo di vivere per accedere a «vita nuova» (la filosofia) già in questa vita terrena. Pure la riflessione moderna è ricca di spunti in questa direzione, come quelli offerti da Schelling quando, introducendo il concetto di estasi dall’Io, evidenzia che qui non si tratta di mettere fra parentesi solo la prospettiva sensibile, ma anche il pensiero oggettivante e di dirigersi verso un centro personale concreto. Infine Schopenhauer pone in rilievo come il problema metafisico dell’etica consista essenzialmente nella messa fra parentesi dell’egoismo (cfr. le interessantissime analisi contenute in Die beiden Grundprobleme der Ethik), anche se poi rimane ancorato ad una concezione assolutizzante dell’ego stesso, tanto da ritenere che la sua scomparsa conduca inevitabilmente nel Nirvana.
L’etica non richiede però di depauperare la nostra esistenza terrena in nome di valori ultraterreni, ma al contrario è un invito a renderla più ricca e intensa. Bisogna voler veramente bene a se stessi per riuscire a superare l’egoismo. Non si tratta in nessun caso di condannare preventivamente un egoismo inteso come orgoglio per il proprio essere relativo e capace di riconosce all’altro un eguale diritto; in un primo moment
- Note:
- Recensioni:
F. Bosio, Verifiche, 3-4/1999, pp. 238-242.
G. Mancuso, Rivista di storia della filosofia, 2/2000, pp. 315-320.
D. Sacchi, Rivista di filosofia neoscolastica, Gennaio-Marzo 2001,142-151.
Dalla Prefazione di M. Frings:
«Il libro di Guido Cusinato non solo riesce a mettere in evidenza la molteplice rilevanza della filosofia di Scheler […], ma illumina anche nuovi aspetti e apre nuove prospettive di indagine. Questo obiettivo viene raggiunto da Cusinato con rigore metodologico e attraverso uno sforzo teso a verificare tutta una serie di affermazioni che erano state fatte finora in modo forse un po’ troppo affrettato. Per es. egli dimostra che tutto sommato Scheler non era né un dualista né un panteista, come invece spesso si è sostenuto […] Cusinato offre al lettore elementi finalmente efficaci per rivedere parecchi luoghi comuni. In particolare Cusinato ritiene importante, se non cruciale, per la comprensione di un pensiero molto complesso come quello di Scheler, mettere da parte quella categoria interpretativa del «dualismo» fra spirito e vita, che così spesso è stata invece applicata alla sua metafisica. Al suo posto Cusinato suggerisce di intendere la concezione scheleriana della relazione fra spirito e vita, o meglio, fra spirito e pulsione (Geist e Drang), facendo ricorso ad un termine che compare negli ultimi scritti: quello di interpenetrazione (Durchdringung). […] Cusinato reinterpreta inoltre la tesi di Scheler, secondo cui lo spirito senza Drang e senza i fattori reali (sociologici) della vita è impotente a produrre qualsiasi realtà, facendo notare che l’impotenza dello spirito non può venir però estesa anche alla sfera della persona. […] Il lavoro di Cusinato merita considerazione anche indipendentemente dalle indagini sul pensiero di Scheler in senso stretto. Fra le suggestive analisi che Cusinato svolge su Platone, il Nuovo Testamento, Schelling, Schopenhauer, e su concetti come etica, ego, eros, agape, essere ecc., le più preziose e originali mi sembrano essere quelle relative all’umiltà (Demut). Invece nella maggior parte della letteratura su Scheler l’umiltà, uno dei tre atti morali fondamentali per accedere all’atteggiamento filosofico, non viene neppure menzionata. L’interpretazione che ne dà Cusinato, ponendola a fondamento di una «riduzione catartica» pensata in contrasto con la consueta riduzione husserliana, offre senz’altro spunti promettenti per le indagini future. Chi leggerà la presente opera ne potrà trarre arricchimento non solo in relazione alla ricerca su Scheler ma anche per quanto concerne la ricerca filosofica in generale.» (M. S. Frings, Prefazione, in: G. Cusinato, Katharsis, pp. 6-7).
- Id prodotto:
-
21505
- Handle IRIS:
-
11562/21505
- depositato il:
-
28 dicembre 2012
- ultima modifica:
-
28 ottobre 2022
- Citazione bibliografica:
-
Cusinato, Guido,
Katharsis. La morte dell'ego e il divino come apertura al mondo nella prospettiva di Max Scheler, con una Prefazione di Manfred. Frings, (402 pp.)
,
(Con una Prefazione di Manfred Frings, curatore delle opere di M. Scheler e suo maggiore studioso a livello internazionale)
,
ESI
,
1999
Consulta la scheda completa presente nel
repository istituzionale della Ricerca di Ateneo